|
sei in
EDITORIALI
Letteratura
pag. 8
|
Editoriali,
recensioni e articoli di LETTERATURA
Italiana moderna e contemporanea
|
|
|
|
|
pubblicato
il 21 agosto 2012
Lingua e antropologia.
Un modello per
difendere l’etnia di un popolo
di Pierfranco
Bruni*
L’eredità
linguistica delle comunità Italo – albanesi, e
non solo di queste comunità ma anche di tutte
quelle che si sottolineano per una marcata
incisività linguistica sia sul piano filologico
che di una semantica ben definita nella
struttura sintattico – grammaticale, porta
dentro il proprio vocabolario una articolazione
di forme che vivono di un meticciato intrecciato
tra una forma di condivisione a priori
(risalente alle origini della parola di
appartenenza) e una forma di inclusione tra
l’esistente e la tradizione.
La questione
della lingua, che ha un suo sostrato strutturato
nel tessuto storico del territorio, pone una
problema sia prettamente linguistico che
metafisico riferito alle singole realtà
individuali delle comunità e proprio per questo
va considerata come una “proprietà”. Siamo
proprietà di una lingua perché noi abitiamo la
lingua che diventa non solo una lingua in senso
generale ma una lingua propria lingua attraverso
un assorbimento di cadenze, di ritmi, di
vocaboli.
Da questo
punto di vista il concetto di eredità ha una sua
partitura nell’incontro tra la condivisione e
l’inclusione. Ed è naturale che non solo va
considerata come un patrimonio culturale ma un
patrimonio che viene ad essere attraversato,
condizionato e condizionabile ma anche in grado
di condizionare. In un sistema culturale in cui
la lingua è l’incipit di un processo identitario
è necessario affiancare un valore aperto che è
quello dato dalle antropologie.
La lingua si
lega ai fattori etnici e alle antropologie che
una comunità e un territorio custodiscono. In
altri termini il valore aggiunto alla lingua è
la storia sotto una forma che intreccia le
tradizioni di un popolo, le realtà archeologiche
di un territorio e tutte quelle caratteristiche
che hanno una valenza fortemente etnica. Proprio
per questo ci si deve sentire proprietari della
lingua.
Nelle lingue
dei Balcani e del Mediterraneo i modelli di
linguaggio non sono comprensibili senza
l’eredità storica di quella dimensione che è
etnica e geo-politica. Mi sembra che la presenza
dell’eredità linguistica debba avvalersi sempre
più di una “cofrontiera” che è quella del
sentire l’appartenenza come identità e questa
come visione di una diversità che diventa
capacità comprensiva in un dialogo tra la parola
e la forma delle parole.
La forma, in
sé, chiama in causa il confronto delle diversità
che soltanto in una lettura etnoantropologica è
possibile viverle in un processo in cui civiltà
e popolo sono un tratteggio unico o percorso
come nella affermazione di una profonda
sottolineatura di affermazione, appunto, di
eredità. Ma considerandoci proprietari di una
lingua non possiamo che considerarci abitanti
di una cultura e quando una cultura la si abita
non bisogna abitarla pensando di stare in
affitto ma di viverla come affermazione di un
sistema storico e spirituale.
Quando si
perde una lingua si esce fuori dalla storia,
dalla storia in senso più complessivo ma
soprattutto si esce fuori dalla storia
personale. Perché questa vive in quanto riesce a
custodire il passaggio fondamentale tra la
tradizione, la memoria e il presente.
La lingua non
ha bisogno soltanto della memoria, questa è già
nel sistema ereditario, ma anche della
trasformazione tra il quotidiano e il presente.
La contemporaneità, in fondo, non può smettere
il suo vestito del quotidiano senza perdere il
contatto con il presente e la lingua da sola non
la forza di resistere alla “liquidità” del
presente. Resterebbe come risarcimento di una
memoria in caduta.
Per renderla
viva nella vitalità del presente l’àncora di
salvataggio delle lingue “etniche” non sta nella
difesa della sua eredità semantica soltanto ma
nella percezione, che deve diventare atto
concreto, di recuperare una antropologia dei
linguaggi che diventa scavo esistenziale in un
modello culturale pre-definito nella esistenza
di un popolo e nella durata di una civiltà.
L’antropologia
dei linguaggi non può fare a meno dello scavo
tra storia ed identità che si materializza nella
difesa di un principio portante che è quella
della tutela di ogni riferimento che possa
rimandare al recupero della tradizione. È su
questo piano che si territorializza la
coscientizzazione del legame tra lingua
condivisa e lingua includente.
Una
partecipazione nella dimensione in cui
geo-etnologia, lingua e storia costituiscono dei
parametri di un vissuto la cui testimonianza ci
obbliga a far parlare i modelli antropologici
espressi da un tessuto abitativo che ha come
elementi prioritari l’interazione. Così anche le
forme di folclore assumono una singolarità la
cui visione umanizzante si disegna intorno sia
alla testimonianza della memoria sia intorno
alle esperienze.
La lingua,
comunque, costituisce l’impalcatura la cui
funzione viene ad essere maturata dai linguaggi.
I linguaggi delle comunità etnolinguistiche sono
patrimonio culturale nella loro interezza e
necessitano di parlarsi.
Ecco perché la
funzione della lingua assume una sua specificità
nell’interpretazione antropologica. E credo che
su questa strada ci siano i tasselli per una
sicura difesa di quella eredità che resta come
cifra decodificante di una comunità etnica.
*
Responsabile progetto “Minoranze linguistiche ed
etnie” del Ministero per i beni e le attività
culturali – Direzione generale per i beni
librari, le biblioteche e il diritto d’autore
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato l' 8 Novembre 2011
“LA NUOVA
PRIMAVERA DEI GIOVANI”
di
Maria Zanoni
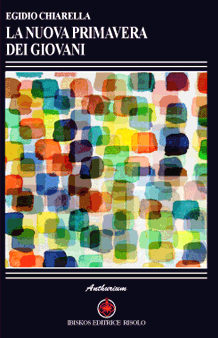 Il
romanzo di Egidio Chiarella “La nuova
primavera dei giovani” (Ibiskos Editrice - 2011)
merita più di una lettura, più di una
riflessione, più di una disquisizione. Il
romanzo di Egidio Chiarella “La nuova
primavera dei giovani” (Ibiskos Editrice - 2011)
merita più di una lettura, più di una
riflessione, più di una disquisizione.
In stile
scorrevole e con chiarezza di linguaggio, il
testo analizza temi interessanti e delicati,
alla luce di un'etica di ordine universale
improntata all'antropologia cristiana.
Sono 183
pagine che fanno intuire, pensare, ragionare,
ricercare, capire.
I tanti
interrogativi esistenziali, le problematiche di
scottante attualità, che sono dei personaggi,
sono dello scrittore e sono anche del lettore,
sembrano prendere il sopravvento, e,
coinvolgendo nel profondo, invitano alla
riflessione, al confronto dialettico sui grandi
temi della cultura contemporanea.
Pagina dopo pagina si
scopre e si apprezza
una cultura
straordinaria, un'invidiabile apertura mentale
di chi scrive per comunicare un vissuto, un
ricco patrimonio di cultura ideale, e si
scopre l’autenticità del narrato, nel suo
intrinseco potere di trasformare la società.
Il genere
“romanzo” per Chiarella non è solo un modello
letterario, ma anche esistenziale. Qui lo
scrittore s’incammina attraverso gli intricati
meandri del racconto realistico che accoglie
volentieri l’invenzione, il verosimile
intrigante, a volte necessario, che porta con sé
ricordi e metafore, nella consapevole ricerca di
sé.
Già nel titolo
prorompe la voce interiore dell’Autore, la
speranza riposta nelle nuove generazioni, che,
“guardando verso il cielo”, con i piedi ben
fermi sulla terra, sappiano coltivare i giusti
valori, per opporsi ai
pericoli ed
alle insidie del sistema di vita post-moderno.
Con buona
volontà ed un grande amore cristiano, lo
scrittore pensa all’impegno educativo nei
confronti della giovane generazione come
l’azione esercitata dagli adulti, come
intervento sociale intergenerazionale, atto a
favorire la maturazione umana e culturale degli
adolescenti, nonchè la loro sicurezza sociale.
Il prof. Teo
(anche la scelta del nome porta con sé valori
metaforici) e Padre Anselmo nei loro contributi
alle discussioni, non trasmettono modelli
culturali preconfezionati e stantii, non
travasano nei giovani interlocutori la cultura
degli adulti, bensì offrono loro la possibilità
di sviluppare coscienza critica, di evidenziare
le capacità e le potenzialità di giovani
desiderosi di essere protagonisti del futuro.
Il legame
spirituale tra le vecchie e le nuove generazioni
è rappresentato dagli ideali e dai valori
morali. Solo così è possibile un dialogo
intergenerazionale, in una società in cui
prevale l’egoismo sfrenato, il giovanilismo a
tutti i costi, la ricerca del benessere, del
tutto e subito, senza limiti. In tale contesto
il dialogo, la comunicazione sociale, diventano
estremamente difficili.
Sono diversi i
linguaggi, il vissuto e le esperienze di ognuno,
quindi le culture, i metodi, le scelte. La
distanza tra “vecchi e giovani” (per dirla con
Pirandello) può essere ridotta, se non colmata,
con l’educazione sociale, con il giusto dialogo.
Così
Teo-Anselmo-Egidio, narrando, sostiene, aiuta,
promuove la crescita umana ed intellettuale di
tanti Vanessa, Luigi, Elena, Alessandro,
Vittorio...
Tra le righe,
nel confronto dialettico-sociale, si suggerisce
la propensione all’ascolto ed al rispetto
dell’idea dell’altro, per l’arricchimento
personale. Così le discussioni della
vacanza-studio su etica, economia, religione,
vanità, cupidigia, diventano strumento di
orientamento nello studio e nel lavoro, guida
alla ricerca di una propria collocazione nella
società, con prospettive di futuro e di migliore
qualità di vita, all’interno di processi storici
in continua evoluzione. Dunque, diventano
stimolo ad un rinnovamento della società, ad un
nuovo Risorgimento Italiano.
E non
dimentichiamo che da molti anni Egidio Chiarella
si sta spendendo in prima persona anche per il
nuovo rinascimento di una regione martoriata
come la Calabria. Alla Fiera della Cultura a
Roma nel 2006, infatti, rivolgendosi ai
numerosissimi giovani presenti al meeting, ha
incitato all’impegno, per arginare l’emigrazione
delle giovani eccellenze calabresi.
Ed in questo suo recente lavoro, mettendo in
gioco prima di tutto se stesso, riafferma con
forza l’esigenza-necessità di un’agorà, “una
Sinagoga del Sabato”, dove
il confronto
ed il dibattito siano il perno attorno al quale
ruota lo sviluppo sociale, economico e culturale
del Paese.
Chiarella, in
questa sua pubblicazione, usando un linguaggio
adeguato e proponendo contenuti interessanti, sa
ben dosare le sue verità generazionali, in
quanto educatore, e sa ben aprirsi agli apporti
giovanili, altrettanto interessanti.
E qui ha
giocato certamente un ruolo decisivo per l’uomo
impegnato da anni nel sociale e nella politica,
la vicinanza, il ritorno temporaneo al contatto
diretto con giovani studenti, nel luogo più
appropriato per delucidare problemi, cercare
soluzioni e dare risposte. Proprio allora, il
Prof. ha preso coscienza che le nuove
generazioni studentesche sono cambiate e, nel
bene o nel male, sono diventate compagne di un
difficoltoso viaggio alla ricerca della
definizione della propria identità, nel rispetto
della reciproca libertà.
Oggi i giovani
hanno molto da insegnare, in alcuni campi, agli
adulti, soprattutto in questo tempo d’incontro
con altre culture. Anni addietro l’insegnante
aveva un ruolo fisso in cui l’esperienza era
determinante, e se era anche anziano era più
autorevole. Nella complessa società odierna, è
autorevole e dà certezze chi è innovativo e
propone idee nuove, anche se giovane.
Ma con il
crollo delle ideologie, con la mancanza di punti
di riferimento, si rischia di perdersi in questo
grande mare; ecco allora il bisogno di una guida
che ponga in primo piano il confronto. E proprio
la crisi dei valori ideali appare oggi
determinante nel generale smarrimento e senso di
solitudine nelle giovani generazioni.
Per il Prof.
Chiarella è la famiglia che, in simbiosi con la
Scuola e la Chiesa, deve riservare la giusta
dose di attenzione ai giovani, “svolgendo il suo
fondamentale ruolo educativo”, onde evitare che
si determini “nel progresso sociale e civile di
una comunità un vulnus capace di ritardare il
suo stesso avanzamento democratico”.
Nella seconda
parte del volume, dopo una lucida analisi della
condizione della Scuola italiana, è riservato
ampio spazio al confronto su impegnativi temi
religiosi.
“La carità
cristiana, l’amore... la pietà... la
solidarietà... sono il tentativo concreto di
intervenire per la nostra parte, piccola o
grande che sia, nel rinnovamento materiale e
spirituale del nostro pianeta” (fa dire lo
scrittore a Padre Anselmo - sua anima
teologica).
Il volume
chiude con l’auspicio di un serio programma di
interveti in cui in sinergia tra loro “le
energie migliori della politica, della
produttività locale, della cultura, delle
associazioni laiche, d’intesa con le Presidenze
delle Regioni e la Conferenza Episcopale locale”
possano lavorare per superare la crisi in atto,
offrendo un futuro ai giovani, assetati di
“Libertà”, quella vera.
In
conclusione, questo romanzo di uno scrittore
impegnato, come Chiarella, è a “tesi”. Ha
qualcosa da offrire al mondo, perchè venga
condiviso. Scommessa impegnativa, ma possibile.
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 1° ottobre 2011
Giuseppe Garibaldi nel racconto di Alexandre
Dumas
L’antropologia del viaggio risorgimentale
di Pierfranco Bruni
 Anche il Risorgimento e i
processi che hanno caratterizzato l’Ottocento
italiano hanno bisogno di una lettura e
interpretazione etno – antropologica a
cominciare dal rapporto tra Garibaldi e il Sud e
Garibaldi e la presenza di scrittori viaggianti
come Alexandre Dumas. Anche il Risorgimento e i
processi che hanno caratterizzato l’Ottocento
italiano hanno bisogno di una lettura e
interpretazione etno – antropologica a
cominciare dal rapporto tra Garibaldi e il Sud e
Garibaldi e la presenza di scrittori viaggianti
come Alexandre Dumas.
Perché nel Risorgimento (o nel
dibattito sul discusso Risorgimento come
processo storico o come concetto etico e
filosofico) resistono quei personaggi ai quali
l’immaginario rivoluzionario ha segnato una
dimensione centrale? Ci sono domande che restano
ancora appese al filo del pensiero non tanto
storico quanto “retorico”.
Ma la retorica del rivoluzionario
ha una sua importanza proprio nel momento in cui
i fenomeni storici si prestano ad una chiave di
lettura più articolata. Cosa resta il Mazzini
carbonaro o il Mazzini “profeta” secondo la
lettura di Giovanni Gentile? Cosa resta il
Garibaldi rivoluzionario dei Mille o quello di
Caprera? Perché primeggia la figura di Maria
Sofia su quella di Francesco II? Perché il
brigantaggio politico è diventato non solo
elemento di contesa “ideologica” (lo è dalle
sottolineature che nel 1924 Togliatti offriva
nei suoi articoli) ma di attualità per capire
sia la fase post unitaria sia per dare voce a un
Risorgimento con più chiavi di lettura?
La letteratura, a volte, ci offre
sguardi peculiari per comprendere sia la storia
che i personaggi soprattutto perché penetra
fenomeni che sono etno – antropologici. Il
Risorgimento oggi può essere letto senza una
visione complessiva degli aspetti antropologici
o etnici? Garibaldi stesso non è forse un
personaggio che rientra nell’antropologia
risorgimentale?
È naturale che la figura di
Giuseppe Garibaldi non può essere consegnata
soltanto al mito ma è necessario una
rivisitazione storica del rapporto tra Mazzini e
Garibaldi e tra Cavour e lo stesso Garibaldi.
Dopo l’incontro tra Garibaldi e Vittorio
Emanuele II le sorti del “libertario” Garibaldi
mutano completamente.
Lo stesso Garibaldi si rende
conto che sono venuti meno gli accordi per una
regolarizzazione e legittimazione, nel nome
della libertà, dell’Unità d’Italia intesa come
atto di pacificazione e di equilibrio
all’interno dei due Regni: quello Sabaudo e
quello Borbonico. Garibaldi viene isolato per
poter realizzare il progetto cavouriano e
sabaudo che era ben altro. Proprio sulla scia di
questo disaccordo si innesta la questione del
brigantaggio politico. Una delle figure
splendide che emerge nello spaccato tra il 1859
e 1861 è quella di Maria Sofia di Baviera,
consorte, appunto di Francesco II di Borbone.
Soprattutto la letteratura ha raccontato uno
spaccato di storia filtrata attraverso la
raffigurazione e la centralità di alcuni
personaggi. Ma il fenomeno del brigantaggio va
riconsegnato ad uno studio approfondito e ad una
visione ideologica meno precaria e anche
attraverso la peculiarità antropologica di
alcuni romanzi: penso a “L’eredità della
Priora” di Carlo Alianello. Già Vincenzo Padula
sosteneva che era necessaria una distinzione tra
brigantaggio politico e il brigantaggio
dell’inizio dell’Ottocento, i quali sono due
aspetti completamente diversi sia dal punto di
vista della temperie storica sia in merito alla
contestualizzazione socio – economica.
C’è da dire che all’interno del fenomeno
complessivo sulle fasi del brigantaggio politico
e ad una ricontestualizzazione dell’Unità
d’Italia all’interno del Risorgimento il
brigantaggio è da considerarsi un processo
spontaneo e non va dimenticato che briganti come
Carmine Crocco o Ninco Nanco nascono proprio
dalle file garibaldine.
L’immaginario storico entra in un contesto
propriamente etno – antropologica dei territori.
Il racconto popolare, in questi casi, è
testimonianza vibrante. Carmine Crocco aveva
partecipato alla spedizione dei Mille e da
garibaldino diventa un anti sabaudo per
difendere il ceto popolare ma davanti alla
militarizzazione dei Cialdini guidati dalle
teorie cavouriane e all’imperversare della
guerra civile assume le difese di quei “cafoni”
che lottano per un pezzo di terra.
Ma Garibaldi è un personaggio nel
mito perché l’immagine che si è data è quella di
un rivoluzionario e resiste sino a quando il
rivoluzionario come immaginario (pur nella
storia) resta centrale. Nel momento in ci viene
isolato, esiliato, allontanato entra nel
paesaggio della memoria e lo si recupera
soltanto attraverso un’operazione che è quella
mitico – letteraria.
A raccontare le avventure garibaldine non ci
sono soltanto gli scrittori italiani ma anche
quelli stranieri, i quali definiscono, in una
dimensione geografica ma anche geo-politica, una
lettura storica che diventa interpretazione e
dimensione antropologica.
Alexandre Dumas (Alexandre
Dumas, padre, 1803 – 1870) che
scrive le memorabili ”Memoires de Garibaldi”
risalente al 1860 e poi “I garibaldini” (Les
Garibaldiens, 1861) scritto
proprio al seguito della spedizione dei Mille
usa delle pennellate non soltanto letterarie o
incise in una particolare angolatura storica ma
si serve soprattutto di una penetrazione
antropologica ponendo accanto alle “imprese” la
descrizione dei luoghi, del paesaggio, della
realtà che si racconta all’interno di un vissuto
che è dato dalla vicinanza tra lo scrittore e
Garibaldi stesso.
Si tratta di un percorso narrante che scava nei
fatti e che riporta sulla scena anche degli
aneddoti che permettono, oltre la retorica, di
scavare nel vivo, l’impresa garibaldina. Uno
spaccato interessantissimo perché attraverso
Dumas si ricrea una atmosfera particolare che è
quella che vede protagonista certamente
Garibaldi ma emerge il bisogno di credere di
poter cambiare un mondo che andava in sfacelo.
Ma cosa fa Dumas? Vive in prima persona le
avventure garibaldine all’interno di una
partecipazione che non è propriamente politica
ma culturale ed è qui che le sfaccettature
antropologiche prendono il sopravvento. Viaggia
in quel Regno di Napoli attraversando paesi e
comunità. Garibaldi lo nomina direttore dei
musei e a seguito dei garibaldini commenta e
annota imprese e paesaggi.
Viene stimato e considerato tanto che in
Calabria il Comune di San Marco Argentano lo
storicizza con queste parole: “L’illustre
Alesandro Doumas è dichiarato cittadino di
Sammarco Argentano, considerando che si
devono raccomandare alla gratitudine dei posteri
italiani quegli egreggi [sic] uomini che a
qualunque nazione appartengono si adoperano a
rendere opportuni servigi all’Italia;
considerando che i due periodi di tempo
abbisognanti di ajuto sono stati per l’Italia la
splendida rivoluzione del ’60 ed i giorni
nefasti del brigantaggio, considerando che
l’illustre Alesandro [sic] Dumas fu appunto uno
di quei egreggi [sic], che resero all’Italia il
nobile uffizio di aiutare la rivoluzione con
ogni sorte di mezzi e d’illuminare la pubblica
opinione sulle cagioni del brigantaggio e sui
rimedi d’esso”. Si trova scritto così su
una delibera del Consiglio Comunale di San Marco
Argentano alla data del 22 novembre del 1863.
A raccontare altre notarelle sul Dumas al
seguito di Garibaldi è stato Giuseppe Cesare
Abba nel suo Da Quarto al Volturno.
Noterelle di uno dei mille.
Anche qui il valore antropologico assume una
rilevante significativa. Il viaggiatore e
scrittore Dumas ha contribuito a dare un senso
al mito garibaldino e lo ha fatto vivendo in
prima persona la storia di una impresa. Una
storia che non può fare a meno di quegli
elementi che sono intrisi di uno scavo etno –
antropologico vero e proprio.
Cosa resta
del personaggio? O cosa resta dei personaggi. Il
fatto è che in questa Unità d’Italia non basta
soltanto la storia tout court dei territori. Il
Risorgimento ha valore se non lo si lega
soltanto alle imprese e alla storia politica. Ma
si trasmette grazie, nella sua complessità, a
quei fattori che hanno una rilevanza fortemente
legata al territorio. Ovvero a presupposti
fortemente radicanti.
L’immaginario ha un senso e proprio per questo
un Risorgimento e una lettura dell’Unità
d’Italia (nella fase pre e post) nella sua
completezza necessitano di una scavo
profondamente antropologico in cui le presenze
linguistiche, etniche, simboliche nelle varianti
più possibili possano costituire incisi nella
civiltà di un popolo.
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 1° ottobre 2011
Il
centenario della morte di Pascoli
UN POETA “SDOPPIATO” TRA CARDUCCI
E I CONTEMPORANEI
Incomprensibile a Vincenzo Cardarelli
di Pierfranco
Bruni
 Tra
Giosue Carducci (morto nel 1907) e la poesia
moderna (in un certo qual modo a cominciare da
“La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio)
c’è di mezzo un poeta che ha rotto alcuni schemi
sia semantici che espressivi (la poesia come
innovazione linguistica) che è certamente
Giovanni Pascoli. Non possiamo non sottolineare
il mosaico ottocentesco carducciano che pur
confrontandosi con modelli europei per
quell’epoca molto sperimentali restava, appunto,
ben ancorato nella tradizione tardo Ottocento. Tra
Giosue Carducci (morto nel 1907) e la poesia
moderna (in un certo qual modo a cominciare da
“La pioggia nel pineto” di Gabriele D’Annunzio)
c’è di mezzo un poeta che ha rotto alcuni schemi
sia semantici che espressivi (la poesia come
innovazione linguistica) che è certamente
Giovanni Pascoli. Non possiamo non sottolineare
il mosaico ottocentesco carducciano che pur
confrontandosi con modelli europei per
quell’epoca molto sperimentali restava, appunto,
ben ancorato nella tradizione tardo Ottocento.
Carducci
muore nello stesso anno di un poeta innovativo e
moderno come Sergio Corazzini. Attraverso la
poesia di Corazzini, in quel vibrante segno
“crepuscolare”, ci si apre realmente ad un
Novecento poetico Futurista ed Ermetico. Ma è
D’Annunzio che pone una problematica linguistica
importante proprio attraverso linee semantiche e
puramente espressive.
Tracciati che campeggeranno in tutto il
Novecento: da Montale a Cardarelli, da Ungaretti
a Pavese. Pascoli resta una via di mezzo e
propone una chiave di lettura di un verso aperto
sicuramente ai linguaggi comunicativi ma anche
non dimentico di una forte tradizione il cui
humus è nella lezione carducciana.
È
proprio Vincenzo Cardarelli a proporre una
lettura provocatoria ma che ha la sua
particolare importanza soprattutto per una
interpretazione complessiva dell’opera di
Pascoli pensando al prossimo centenario della
morte. Cardarelli usò queste parole: “Io non ho
da fare a Pascoli altra obbiezione se non
questa: cioè ch’egli è più uno stornellatore, un
verseggiatore elaborato, colto, fine quanto si
vuole, che un poeta. Come dire più discretamente
quanto poca individualità di linguaggio e di
forme metriche (ho detto, senz’altro, i due
elementi costitutivi della poesia) si riscontri
nelle liriche di Pascoli? Chi sa quel che
significhi mettere un pensiero, una sensazione,
un’immagine in forma di discorso lirico non di
maniera, dare alle parole un tono non
indifferente, sa pure (se è lecito parlare con
la nostra autorità di lettori, dimenticando di
essere anche noi gente che s’arrischia a fare
poesia) che cosa io voglio dire”.
Una
precisazione dura ma singolare che oggi andrebbe
ripresa per un più accorta interpretazione.
Nonostante tutto Giovanni Pascoli lo si trova
come chiavistello in molti poeti dal linguaggio
moderno. Si pensi ad alcuni squarci di Sandro
Penna. Un Penna fortemente dannunziano per
alcuni affreschi di paesaggi. Comunque la
rilettura di Giovanni Pascoli nel contesto
contemporaneo ci pone di fronte a questioni di
natura puramente letteraria e naturalmente di
ordine storico – critico. Pascoli, chiaramente,
è stato letto attraverso diverse chiavi
interpretative. Ma ciò che resta fondamentale e
non dovrebbe essere discusso è la preziosità del
senso della memoria che è dentro la parola
“pascoliana”.
La
memoria resta comunque soltanto come passato. Un
passato che è (ed ha) bisogno di fedeltà. E’ una
memoria che non si apre alla possibilità di
futuro perchè è senza avvenire. O meglio, il
futuro resta sempre la riproposta del segno
della memoria. E’ chiaro che è interessante
discutere su Pascoli e il senso della memoria
nella letteratura del Novecento.
Accanto
a Pascoli troviamo i crepuscolari per la storia
che li contraddistingue e li caratterizza.
Accanto a Pascoli troviamo un certo
decadentismo. Accanto a Pascoli troviamo una
fisionomia precisa della letteratura europea. Ma
Pascoli resta un punto intorno al quale
ritornare a meditare. Sia per ciò che riguarda
il suo dettato poetico e il suo viaggio
all’interno del tempo-sogno-cronaca. Sia per ciò
che riguarda la sua fase teoretica.
La
poetica del fanciullino non è assolutamente da
trascurare perché ci offre delle possibilità di
ricerca che non sono soltanto poetiche, ma anche
antropologiche e filosofiche, letterarie e
mitiche. Nel fanciullino c’è il mito e c’è
soprattutto la riscoperta del mito come
riappropriazione dell’infanzia intesa come
spontaneità.
La
memoria nostalgia ridisegna il circuito lirico
di Pascoli. In questo dialogo ciò che si coglie
immediatamente è il sogno. O meglio. Dalla
memoria-nostalgia nasce il sogno del passato.
Ieri era sempre bello. Oggi la tristezza ci
intrappola. E’ questo ciò che domina la voce di
Pascoli.
In una
intervista rilasciata ad Ugo Ojetti Pascoli
diceva: “La poesia non è in ogni caso
razionalità, non procede per sillogismi e non è
nemmeno logicità, non tende a convincere la
mente... il segreto della poesia non sta nella
rima o nel verso, ma in una improvvisa
rivelazione del mondo”.
Rivelazione come magia. Rivelazione come
mistero. Ma è soltanto nel passato, che diventa
memoria-sogno, che la poesia si fa
rivelazione del mondo.
Giovanni
Pascoli era nato a San Mauro di Romagna nel
1855. Muore a Bologna per un male incurabile nel
1912. Myricae è del 1891. Ci sono state
diverse ristampe. Quella definitiva è del 1900.
Nel 1897 apparvero i Primi poemetti. Nel
1903 i Canti di Castelvecchio. Dal 1904
al 1913 abbiamo i Poemi conviviali,
Odi ed Inni, Nuovi poemetti,
Canzoni di re Enzo, Poemi italici,
Poemi del Risorgimento. Pascoli ha scritto
anche delle prose e dei libri di critica.
Con
Myricae si apre il mondo poetico pascoliano.
Già in questo primo libro c’è ormai una precisa
identità poetica non solo sul piano espressivo
ma anche tematico. I poli tematici che
caratterizzano l’intera dimensione pascoliana
sono tutti calati in questo primo libro. Il
paese, le radici, il padre, la famiglia, la
natura non sono echi. Sono esiti fondamentali.
In
Pascoli attraverso il significato poetico della
memoria-nostalgia emerge il sogno del
ritorno. Il ritorno è un sogno perché la memoria
è sogno. C’è una poesia dal titolo il “Sogno” in
cui primi quattro versi recitano: “Per un attimo
fui nel mio villaggio,/nella mia casa. Nulla era
mutato./Stanco tornavo, come da un
viaggio;/stanco, al mio padre, ai morti, ero
tornato”.
In fondo
Pascoli è il poeta del ritorno. E appunto nel
ritorno che la sua vita si compie e si realizza
così il grande messaggio della nostalgia. Un
ritorno che si dichiara nella metafora ma che
non può giocare la sua partita fino allo
strazio. Il dolore è ferita che sanguina. Ma il
ritorno resta comunque un sogno-metafora perché
in Pascoli non c’è il futuro. C’è la profonda
melanconia che lacera l’anima ma non c’è la
religiosità o l’illusione dell’attesa compiuta.
La
mancanza di futuro d’altronde è l’impossibilità
del ritorno. In una poesia dei Canti di
Castelvecchio si ascoltano gli ultimi versi:
“Oh! Tardi! Il nido ch’è due nidi al cuore,/ha
fame in mezzo a tante cose morte;/e l’anno è
morto, ed anche il giorno muore,/e il tuono
muglia, e il vento urla più forte,/e l’acqua
fruscia, ed è già notte oscura,/e quello ch’era
non sarà mai più” ( da “In ritardo”).
“Pascoli
– scrive Francesco Grisi nel suo I Crepuscoli
(Newton Compton) – è sempre sdoppiato. C’è
la vita (che è quella che è) e la sua esistenza
(che non coincide con la sua vita). Esamina e si
dispera nel suo sdoppiamento. Vorrebbe fare
coincidere i due momenti. Ma è una speranza
irrealizzabile. In Pascoli e nel crepuscolari
non c’è avvenire. Si dibattono disperatamente
anche con un certo languore narcisistico. Ma
Pascoli, a suo modo, è un moralista. E mistero
con le sue stazioni di servizio: l’abbandono, la
volontaria viltà, l’aberrazione,
l’infamia, la solitudine. E, al limite, un
delirio liberatorio che, riconoscendo in sé il
peccato, gli dà la forza e il diritto di
denunciare”.
Lo
sdoppiamento in Pascoli è talmente forte tanto
da sentirsi sempre più solo. La solitudine non è
più sogno. E appunto la solitudine che fa
rompere a Pascoli il miraggio del
ritorno. La solitudine fa capire a Pascoli che
la vita ha le sue rotture.
E allora la
memoria-nostalgia è sogno e Pascoli viene
straziato da questo sogno: “Nel mio cantuccio
d’ombra romita/lascia ch’io pianga su la mia
vita!” (da Canti di Castelvecchio in
“L’ora di Barga”).
L’attualità di Pascoli? E’ chiaro che con
Pascoli andrebbe riletta la letteratura del
primo Novecento. La sua attualità è nel saper
leggere non solo la sua poesia ma l’intero
contesto storico e letterario in cui è vissuto.
Non so se è possibile parlare di un Pascoli
attuale. Credo, invece, che ogni poeta vive
all’interno del proprio contesto con rimandi
letterari e linguistici che provengono da una
precisa formazione.
In
Pascoli resta vitale un percorso carducciano.
Cosa che non si evidenzia in modo straordinario
in D’Annunzio. Ma Pascoli, comunque, resta un
filtro importante per le generazioni successive
e forse anche un filtro necessario. Ma oggi non
è più un riferimento come non lo è chiaramente
Carducci.
D’Annunzio invece resiste. Soprattutto per
alcuni aspetti poetici risulta ancora
l’apripista per una poesia che non ha accettato
le griglie semantiche tradizionali. La stessa
poetica di Montale non è pensabile senza
comprendere i riferimenti dannunziani. Così lo
si avverte in Cardarelli, in Pavese e in quella
recita mediterranea che va da Salvatore
Quasimodo a Raffaele Carrieri.
Ma la
storia della poesia è nell’intreccio delle
poetiche che si dichiarano attraverso i poeti e
le dimensioni liriche. C’è un Novecento poetico
(con i suoi richiami e i suoi rimandi a un mondo
pregresso) che non si dissolve e resta come
testimonianza a dimostrazione di temperie che
vanno rilette senza dimenticare il presente e
senza dimenticare di confrontarsi con il
linguaggio contemporaneo (nel quotidiano della
letteratura) e senza sfuggire al rapporto tra
letteratura e ricerca linguistica all’interno
dei vari passaggi epocali. in questo percorso
pascoliano è l’ulissismo presente nella poesia
di Pascoli con un approfondimento dei Poemi
conviviali.
Ulissismo e mediterraneo. Ma cerchiamo di dare
un senso a questo annuncio celebrante dell’opera
di Pascoli.
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 18 maggio 2011
Il Mediterraneo
delle parole oltre il Mediterraneo delle statue
Da Kavafis a
Calabrò, da Elitis a Pascoli, da Pavese a
Seferis, da Theodorakis ad Abshu
di Pierfranco
Bruni
 Il
Mediterraneo delle statue e del racconto
affidato ai musei. Il Mediterraneo delle parole
e dei linguaggi. Il Mediterraneo degli incontri
imprevedibili tra Ulisse, Cristo e Maometto. Il
Mediterraneo ancora degli Orienti (i più Orienti
che abbiano nella nostra storia e nelle nostre
memorie) e dell’Occidente. Ma in un Mediterraneo
che ha un cruore cristiano, musulmano, berbero,
ebraico, armeno (intrecciamo religioni e
civiltà), greco e Magno – greco la letteratura
diventa il meridiano dell’attesa. Il
Mediterraneo delle statue e del racconto
affidato ai musei. Il Mediterraneo delle parole
e dei linguaggi. Il Mediterraneo degli incontri
imprevedibili tra Ulisse, Cristo e Maometto. Il
Mediterraneo ancora degli Orienti (i più Orienti
che abbiano nella nostra storia e nelle nostre
memorie) e dell’Occidente. Ma in un Mediterraneo
che ha un cruore cristiano, musulmano, berbero,
ebraico, armeno (intrecciamo religioni e
civiltà), greco e Magno – greco la letteratura
diventa il meridiano dell’attesa.
Non solo il
pensiero meridiano disegnato da Albert Camus ma
anche quell’orizzonte degli abbracci tra il
mare, metafora del tutto, e il deserto (metafora
del comunque sempre), ovvero dell’acqua e della
terra. La Bibbia ci recita la durezza dello
sguardo dei padri del deserto con la dolcezza
delle parole e così ci porta, altresì, lungo il
cantico che Salomone ha raccolto come i cantici
dell’ebbrezza tra le colombe e i danzatori
dervisci.
C’è una poesia
nella grecità soffusa che ha un immaginario
turco, islamico, berbero come i cavalli del
deserto che si dirigono verso le acque dei fiumi
o le distese dei mari. C’è una letteratura che
non ha inteso mai confrontarsi con la ragione,
divieto manifesta di una poetica dello sguardo e
del mistero. Il “Capitano Ulisse” di Alberto
Savinio ci indirizza verso le isole
dell’impossibile che diventano decifrabili ma
indefinibili se manca l’amplesso tra Odisseo e
Circe.
Un
Mediterraneo, dunque, non delle fate ma delle
streghe. “Da Lipari ad Alicudi/piano piano si
fredda/il mare/ch’è un immenso bacile d’olio
grigio”: una geografia degli incisi nella
parola delle metafore percettibili ma mai
descrivibili con Corrado Calabrò che al
mediterraneo ha dato il senso dei linguaggi. Ma
il Mediterraneo è l’immenso mare degli
Adriatici, dei Tirreni, dei paesaggi sullo
Jonio, dello suardo intenso di Cleopatra e dei
fili intrecciati nella Mesopotamia dei segni..
Odisseo
cammina tra le grotte della finzione per
condurci non chissà dove ma per portarci mano
nel vento lungo la comprensione di ciò che il
Mediterraneo è stato. Quello che è stato non è.
Non possiamo vivere il Mediterraneo dei nostri
giorni pensando soltanto ad Omero. Perché, come
recita Odisseo Elitis, il ricordo è libertà. “La
grecia che con passo sicuro entra nel mare/La
Grecia che sempre mi reca in viaggio/Su monti
nudi gloriosi di neve”.
Elitis ci
recita il canto delle “tessitrici del sole”. Una
mediterranea grecità e Calabrò intaglia i suoi
versi dalla fisicità greca a quella dei
“mercanti di pietra” che hanno la simbologia
segnata negli occhi. Questo è Mediterraneo. Ed è
il Mediterraneo di Costantino Kavafis che ci fa
rivivere l’incanto e il disincanto dei Troiani:
“Sono gli sforzi di noi sventurati,/sono, gli
sforzi nostri, gli sforzi dei Troiani. (…)/Dei
nostri giorni piangono memorie,
sentimenti./Pianto amaro di Priamo e d’Ecuba su
noi”. Un viaggiare nella grecità del
Mediterraneo senza perdere l’essenza dello
sguardo di Ritsos o di Hikmet sino a toccare
la lirica sufi e il mare che ad Ulisse sempre ci
conduce.
Perchè alla
fine tutto ci conduce ad Ulisse? Giorgio Seferis
nelle nostalgie che cerchiamo e attutiamo ci
sfida: “Il mare: e come è divenuto questo il
mare?/Anni indugiai sui monti,/accecato da
Lucciole./Ora su questo litorale aspetto/che
attracchi un uomo/un relitto, una zattera”. Sino
all’Ulisse di Pascoli e a quella figura di
Penelope o a Pavese che raccoglie nel mito di
Calipso il cammino dell’immortalità. Cosa
accetti Odisseo? La vita che è l’amore o
l’immortalità? La Calipso di Pavese nel cuore
del Mediterraneo di Leucò. E Pascoli nei suoi
“Poemi Conviviali” (l’unici testo che di Pascoli
oggi resta): “E gli dicea la veneranda
moglie:/’Divo Odisseo, mi sembra oggi quel
giorno/che ti rividi. Io ti sedea di
contro,/qui, nel mio seggio. Stanco eri di
mare,/eri, divo Odisseo, sazio di sangue!/Come
ora. Muto io ti vedeva al lume/del focolare,
fissi gli occhi in giù”.
Ma questo è il
Mediterraneo che abbiamo sempre accolto nel
nostro pellegrinaggio di voci e di destini. Un
pellegrinaggio metafisico che raccoglie, tra
l’altro, sia le istanze di Omero, di Virgilio ma
soprattutto di San Paolo. Ma la poesia non ha
mai confini e non si lascia aggredire dagli
orizzonti spersi tra le nuvole. La poesia ci
tocca e toccandoci ci penetra. Penetrare. La
poesia è un lento penetrare. Il Mediterraneo non
può essere capito se si escludono le parole, le
immagini, gli sguardi. E l’amore è nella
intensità delle perdute nostalgie.
La grecità di
Calabrò: “Entra – se puoi – nell’anima,/entra
nei miei occhi senza farmi male/così come,
all’ingresso del porto,/le navi s’introducono
incorporee/nell’azzurra vetrata del
Naxos.//Appena oltrepassata Filicudi/s’erge nel
mare una stele votiva/dall’acqua blu cobalto che
sprofonda”. Già, le isole sono una metafora
nella fisicità dei luoghi ma non sono
musealizzabili.
Il
Mediterraneo greco ha la danza delle odalische o
delle zingare (come ci canta Franco Battiato) o
dei dervisci tra i camini delle fate della
Cappadocia. Ma l’amore è l’immenso travolgente
luogo dell’esistere: “Solo chi l’ha bevuto
racconta/-come una storia di pesca fatata-/d’una
vela scorrente sull’acqua,/gravida del pallore
della luna,/che una sera si trova riflessa/nella
vetrata che l’aspetta in sorte”: è ancora
Corrado Calabrò nel suo sottosuolo dell’anima
che intriga il fremito dei corpi con la
stregoneria che il mare, la donna,il viaggio si
portano dentro.
Ed è un
Mediterraneo stregato o stregone che raccoglie
l’orizzonte e le linee della cristianità con le
eresie di Nazhim Abashu, poeta musulmano
convertitosi al cristianesimo, che incentra la
danza delle sue parole sul senso della croce e
poi sprigiona sulla “talassia” del vento le
erosioni e il terribile eros: “Se non ci fosse
il vento delle maree mediterranee/io sarei
rimasto a custodire la sabbia di Tunisi/ma tu,
amante mia, porti negli occhi le banderuole de
naufragi e della salvezza”.
Cosa è questo
Mediterraneo della parola. La parola è sempre un
fluttuare di acque nell’anima che è destino di
civiltà. “L’Egeo s’è rizzato e mi guarda/-Sei
tu? Mi chiede./-Sì, gli rispondo, sono
io/insieme ad un altro,/non lo conosci?/ma
quest’altro/sei tu!/L’Egeo s’è coricato/il Sole
ha tossito/son rimasto solo/del tutto solo”.
Mikes Theodorakis in questi suoi versi il gioco
delle geografie è sempre più un incastro. Ma è
una canzone libera in cui la grecità è nello
scavo dei luoghi e del luogo che si porta dentro
come una paese del fascino intoccabile.
Chi può
mettere una mano su questo mistero? Il mistero è
intoccabile e forse è invisibile se non
attraverso le emozioni della percezione. Il
Mediterraneo delle parole o anche delle etnie
che si incontrano nei linguaggi. Ma cosa ci
permette di comunicare e di attraversare questa
comunicazione? La poesia. Impercettibile come le
conchiglie, le foglie, le stelle di Odisseo
Elitis. Ma le parole possono essere affidate
alla musealizzazione?
Il
Mediterraneo che troviamo nei Musei, le statue
del Mediterraneo, le archeologie del
Mediterraneo, le maschere, i vasi, i frammenti
sono la memoria scavata che ritorna a farsi
sentire e ci chiede di essere ascoltata. Il
Mediterraneo delle parole è il “Mediterraneo dei
silenzi mai definiti nelle voci” ci dice Abshu e
questo Mediterraneo non ha neppure bisogno di
memorie perché in ogni parola la dimensione
delle immagini non ha stratigrafie di terreni ma
palpiti, sensazioni, percezioni.
Il
Mediterraneo della poesia è altro dal
Mediterraneo dei musei. Le parole non hanno
fisicità e non sono oggetto. “Non toccarmi
l’anima/tu donna dei Mediterranei perduti/ho già
camminato sulla sabbia del tuo deserto/e non ho
sguardi da consegnarti/il rumore che ascolti non
ha tempo/il suono della cetra ha l’odore
dell’incenso/e le stanze che abiti sono paesi di
infinito/il Mediterraneo lo porti con te”.
È Nazhim Abshu
nel teatro dei Mediterranei che includono ad
definirsi tra le parole intoccabili,
inafferrabili, leggere come il vento che soffia
nel fluttuare delle maree. In questo fluttuare
le parole inafferrabili sono le parole del
mistero avvolgente: da Kavafis a Savinio, da
Camus a Calabrò, da Elitis a Pascoli, da Pavese
a Seferis, da Teodorakis ad Abshu.
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 18 maggio 2011
PASSEGIANDO
TRA LE VIE DI FRANCESCO GRISI
NELL’UMANITA’ DI CUTRO
Tra i
luoghi e il racconto della Magna Grecia
di
Pierfranco Bruni
 Passeggiando
tra le vie di Cutro in due giornate di sole e di
pioggia. Per ricordare e raccontare i luoghi di
Francesco Grisi. Lo scrittore che nonostante sia
nato a Vittorio Veneto il 9 maggio del 1927 era
fortemente legato a questa Magna Grecia dagli
accenti ellenici e dai colori sfumati, tra le
albe e i crepuscoli, di un Mediterraneo che
recita i segni e i numeri di Pitagora. Passeggiando
tra le vie di Cutro in due giornate di sole e di
pioggia. Per ricordare e raccontare i luoghi di
Francesco Grisi. Lo scrittore che nonostante sia
nato a Vittorio Veneto il 9 maggio del 1927 era
fortemente legato a questa Magna Grecia dagli
accenti ellenici e dai colori sfumati, tra le
albe e i crepuscoli, di un Mediterraneo che
recita i segni e i numeri di Pitagora.
Due giornate
sempre costantemente accompagnati dal sindaco
Salvatore Migale. Questo sindaco che volle
fortemente che Grisi restasse cittadino onorario
di Cutro e al quale l’Amministrazione Comunale
ha dedicato la Biblioteca Comunale in un
immaginario che è recita e vita.
I genitori di
Francesco erano cutresi. Il padre, maresciallo
dei Carabinieri, con la sua famiglia, si
trovava di istanza a Vittorio Veneto. Ma la
calabresità di Francesco resta nel sangue. Nel
sangue delle parole. Di quelle parole che
bussano sempre alla porta del cuore e danno un
senso agli sguardi lungi tra gli orizzonti e il
mare.
Abbiamo
trascorso due giornate nella città di Francesco.
Per la seconda edizione del Premio Nazionale
alla cultura e per un Convegno dedicato agli
scritti Risorgimentali e mazziniani di Grisi.
Scritti che hanno sempre un narrato e una favola
antica tra gli squarci delle voci e le canzoni
che Dorotea, la bella Dorotea con l’accento da
brigante e da regina, ha siglato lungo le
conversazioni del nostro discorrere.
Cutro. Giù il
mare e appena lasciata la strada chiamata 106 si
legge l’ombra, tra la lontananza e la vicinanza
sempre più diretta, il paese – città dal quale
Francesco partiva con lo sciaraballe del nonno
per raggiungere Santa Severina dove egli aveva
studiato negli anni della giovinezza.
Cutro. Una
cittadina che è un riferimento tra una chiesa,
quella chiamata delle “Monachelle”. Splendido
complesso d’arte e di restauro, appena
inaugurata e il Crocefisso dai tre volti o
meglio delle tre espressioni, di cui Francesco
sottolinea i particolari. Basta una angolatura
per leggere i segni di un Cristo che sorride,
che vive l’agonia e che muore tra le attese
della rivelazione. E lascia dentro il silenzio
voci antiche.
Il Convegno
con i versi mazziniani inediti e il Tempio di
Pitagora che scava nella memoria e nel sogno e
ancora con il canto di Dorotea che dava un senso
agli occhi turchini o alla passeggiata su
Posidonia in una danza ritmata.
Tutto ha un
senso. Anche la finestra della nonna dove i
colombi si posavano per raccogliere briciole di
mollica di pane. Quella nonna e quei palazzi tra
le strade dei ricordi che restano a fissare il
tempo perduto.
Una Calabria
che ha una ospitalità profonda in quell’anima
che è leggenda e linguaggio popolare. Il sindaco
ha preannunciato che al prossimo appuntamento ci
sarà un busto che ricorderà l’ironia di
Francesco. E poi un Parco Letterario. E per no?
E poi la biblioteca che custodisce alcuni
segreti sulla cui parete centrale d’apertura
campeggia la sua firma in grande come se fosse
un inciso, un graffito. Anzi un benvenuto.
Abbiamo
parlato del sacro, del mistero, del sogno e dei
viaggi in una Calabria bella e selvaggia che sa
di pane e di sardella. Cutro. Città nazionale
degli scacchi. Città che ha storia raccolte nei
destini. Un gioco nel gioco con gli applausi che
dureranno nei secoli avrebbe detto Francesco
Grisi.
E i colori
sono destino. Sono andato via con nostalgia ma
con i graffi dei simboli nello scavo dei miti di
un Mediterraneo diffuso tra gli accenti delle
donne. Delle donne di Cutro che hanno occhi come
olive e sorrisi marcati sul viso tra gli scogli
del tempo che cammina nel nostro vivere.
Ho passeggiato
nelle mattine delle albe incerte tra i vicoli di
Cutro ed ho trovato il fascino di una
accoglienza che è stile, gentilezza, umanità e
in un abbraccio c’è stata una accoglienza che in
nessun altro luogo ho trovato. Anche i vigili,
nello loro divise, hanno il calore dell’umanità.
Francesco lo diceva spesso. Sono andato via con
malinconia.
Ma
l’appuntamento, gli appuntamenti andranno
avanti. Altri Convegni, altri incontri.
Raccoglieremo le relazioni del Convegno sul
Risorgimento grisiano in un volume. Presto. Per
ritornare a Cutro e discutere con i cutresi di
Francesco, della Calabria, della storia di una
terra che ha l’attraversamento del mistero nel
corpo e negli occhi. Occhi di oliva o occhi
turchini. In una danza che è tutta mediterranea
come la prima sera al Kiterion dove il sorriso è
di casa. Il Premio, il Convegno, il discutere
possono essere un pretesto per ritornare, a
futura memoria, a Francesco Grisi. Ma nulla si
dimentica. Come quell’accento che ci fa capire,
con Pavese, che qui un tempo era tutto greco.
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 28 Febbraio 2011
Il romanzo di una
vita nella vita che si fa romanzo di Bruni
Il destino tra il narrare e
l’alchimia della memoria e del sogno
di Annette
Vicy
 “E’
un libro tra le pagine della vita che si
racconta come foglie in un giardino con un
paesaggio di stagioni e di colori tra le età e i
destini che sempre si incrociano e vivono anche
oltre”. “E’
un libro tra le pagine della vita che si
racconta come foglie in un giardino con un
paesaggio di stagioni e di colori tra le età e i
destini che sempre si incrociano e vivono anche
oltre”.
“LA
BICICLETTA DI MIO PADRE” di Pierfranco
Bruni, nelle librerie in questi giorni, è il
romanzo di una vita. O forse è il romanzo che si
fa vita. Edito dalla Casa editrice Pellegrini in
una veste elegante con sopra coperta nera, vive
lungo le vie di una recita in cui tutto è
possibile. Si incontrano luoghi, nomi, amori e
amore, follia, morte e tragico sentire. Ci si
pone in ascolto. Un romanzo che ha la dolcezza
del tremore, la sensualità dei corpi che si
stringono e si amano ma conoscono l’abbandono e
il distacco, il gioco incantevole della
provvidenza e la capacità di confrontarsi con la
provvisorietà. Il padre è la voce nel silenzio
del camminamento. La bicicletta è il tempo
finito e l’immagine di uno specchio che tutto
riflette.
Si vive tra i
dettagli e in un incantesimo che non bisogna mai
capirlo ma raccoglierlo tra le pieghe del
vissuto nel vivere. Il deserto o il mare. Il
personaggio – io narrante si pone tra le rughe
di questi fogli che non sono ingialliti. E la
risposta è sempre una ruga in più.
Pierfranco
Bruni con questo romanzo conferma di essere un
maestro della parola e un fantasista dei destini
dei personaggi che compaiono e smarriti ritorno
a far festa sotto la tenda e intorno ai falò.
Bruni quasi in
conclusione al romanzo scrive in una breve
annotazione: "Ho veramente combattuto la mia
buona battaglia? Devo spiegare le vele. Potrei
essere uno sciamano? Tutto si confonde? Tutto si
intreccia. Ma oltre il deserto c'è sempre il
mare. Ho soltanto segnato le rughe che
nascondono le mie giovinezze. Potrò mai
dimenticare i paesi e le donne della mia vita?
Le donne? O gli amori? Gli amori che non ho
nascosto e la passione che mi recita il vero
infinito amore? È rimasta appesa ad una parete
della mia grande casa di paese la bicicletta
nera di mio padre. Resto un lanciatore di sogni
e di alchimie".
Un romanzo tra
le pieghe dei sogni e del vento del tempo nel
quale si racconta la vita di un intellettuale
che non smette di metaforizzare la vita vissuta
attraverso i segni che si leggono nella magia
dei giorni. Sembra un diario. Forse lo è tra le
pagine di mezzo. Ma c’è una storia che sembra
lacerarsi non dal rimpianto, non c’è mai
rimpianto, ma dalla memoria nella quale
convivono sia i ricordi che la nostalgia.
Pierfranco
Bruni ci offre un romanzo vissuto sulla
scacchiera di un linguaggio elegante il cui
senso dell’estetica è un entrare e penetrare il
tessuto della poesia.
La bicicletta
potrebbe essere soltanto un pretesto o ancora
una metafora del tempo che è sempre un
viaggiare. Ma proprio grazie alla bicicletta si
riprende il cammino sotto l’onda di una profonda
spiritualità sia cristiana che sufica con un
interloquire con la misteriosa visione
sciamanica del tempo.
San Paolo
stesso sembra un maestro nello stile sciamanico
e il paesaggio è quello delle lune e del mare.
Dunque, un intellettuale che ha capito che non
occorre cercare e neppure cercarsi ma aspettare
e il vero luogo dell’essere resta la pazienza
legata all’attesa.
C’è attesa
perché l’amore è l’armoniosa conquista
dell’attesa nella pazienza senza il bisogno di
cercare.
Questo
intellettuale che non crede alla ragione prende
tra le mani il seno del mistero che diventa
sfuggevole perché è indefinibile ma giungono i
suoni della vita e di un amore che sembra
fuggire ma resta dentro l’anima e nella
sensualità che scava nello sguardo.
Un romanzo
molto forte e straordinariamente intriso di una
pacata alchimia. Bruni gioca con l’alchimia
dialogando con il passare delle sensazioni.
Dopo “Paese del vento”, “Quando fioriscono i
rovi”, “L’ultima primavera” e “Il mare e la
conchiglia” questo romanzo sembra chiudere un
ciclo.
Cinque romanzi
in cui la storia è assente perché la ragione non
è nella parola e nell’onirico vivere in quanto
nell’io narrante si formano i personaggi.
Come in “La
bicicletta di mio padre”. I personaggi si
intrecciano con l’io narrante e il linguaggio è
un fiume che recita il mistero. L’autore si
rivolge spesso al “caro lettore” per renderlo
personaggio e per portarlo sul teatro di una
recita mai fittizia ma metaforica tra il tempo e
il sogno in una dimensione che ha la sua
alchimia tra gli archetipi e i labirinti.
Ma tutto
sembra avere senso o non senso. Il romanzo è
sempre un viaggio incompiuto come la vita che si
la cera nel tempo.
Bruni è dentro
questo mosaico i cui tasselli sono corde di
musica bell’infinito e nell’indefinibile. Un
romanzo importante di uno scrittore tra le
sponde degli orizzonti che hanno tramonti ma
anche le albe e le aurore.
Si è detto più
volte che questo romanzo è il romanzo di una
vita.
Con questo
romanzo Pierfranco Bruni riconcilia la scrittura
al fascino di un narrare senza storie ma con
grandi immagini che si definiscono nel segno di
una provvidenza che è speranza e religioso oblio
tra le parole e la memoria che continua a vivere
tra le pagine di un viaggiatore che si è fermato
per ascoltare una partita tra le ombre, le
nebbie e le lune oltre la luce.
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 20 Febbraio 2011
TUNISI
NEL MEDITERRANEO DEGLI ESCLUSI
di Pierfranco
Bruni
 Ci sono giochi
di luci sul Mediterraneo che fanno ombre tra le
nuvole e la pioggia. La Sponda Sud, come canta
Eugenio Bennato, è il nostro destino che abita
la memoria. Una memoria che vive tra i tragitti
delle attese nella storia che si ripete mai
uguale ma si ripete con i popoli che vivono le
diaspore e le fughe nella disperazione. Ci sono giochi
di luci sul Mediterraneo che fanno ombre tra le
nuvole e la pioggia. La Sponda Sud, come canta
Eugenio Bennato, è il nostro destino che abita
la memoria. Una memoria che vive tra i tragitti
delle attese nella storia che si ripete mai
uguale ma si ripete con i popoli che vivono le
diaspore e le fughe nella disperazione.
Questo nostro
Mediterraneo di tramonti e di albe è infuocato
dalle etnie, dalle lingue, dalle tradizioni, dai
costumi e da una impercettibile malinconia che
recita la poesia di un Occidente che penetra in
un Oriente tra la durata dei riti e la
trasgressione delle eresie. Ma Tunisi è una
rivolta.
Ho ricordi che
affiorano tra i bagliori dei lanci nelle piazze.
Le donne tunisine, algerine, marocchine hanno
gli occhi rivolti al mare ma il loro sguardo ha
la durezza e la tenerezza del deserto. Sono
stato a Tunisi. Di recente.
Una donna con
il foulard sul capo mi ha detto, mentre
aspettavo il mio turno in aeroporto, con voce
dal ritmo francese e arabo: “Tu sei Mediterraneo
ma non appartieni alla nostra gente. Sei di un
Mediterraneo nobile che ha intrecciato le
civiltà ma non vive tra i luoghi del nostro mare
o negli spazi dei deserti. Conosci il nostro
mare e il deserto come una fotografia e anche se
il tuo viso è avvolto dalle nostre pashmine e
dai nostri colori tu sei altrove. Potrai mai
capire i nostri distacchi, le nostre lontananze,
la nostra parola”.
Mi ha preso la
mano e ancora mi ha detto: “Noi, donne di Tunisi
siamo anche la nostra parola. Tunisine, arabe,
francesi, siciliane. Abbiamo di fronte i limoni
e gli aranceti ma i sapori e le onde degli odori
hanno un’altra natura. Hai avvertito il
dolciastro della Medina? Ti ho visto nella
Medina, l’altra sera fumavi il calice della
pazienza ma era incerto, quasi pauroso. Non sei
uno dei nostri anche se ne porti i segni e il
tuo guardare ha la profondità della pazienza”.
E poi: “Siamo
vissuti e viviamo tra le strade di questa città
ma il nostro cuore è impastato di acqua e di
terra. Di acqua di mare, acqua salata e di
sabbia, una sabbia che ha granelli sottili.
Abbiamo sempre il timore di una sabbia d’acqua o
di una pioggia di sabbia. Per noi andare via è
strappare la sabbia che si fa acqua e l’acqua
che vive nella sabbia della nostra storia”.
Mi ha guardato
a lungo. Poi con gli occhi abbassati si è
allontanata. Non sono riuscito a raggiungerla.
Ho perso il ritmo dei passi e la fila si è
allungata. Una corsa nell’aeroporto di Tunisi ma
non ho trovato il suo profumo di donna nella
malinconia della partenza o di donna nella
nostalgia del ritorno.
Tunisi è un
immaginario nella realtà. La Tunisi che ho
conosciuta alcuni anni fa. Dei miei incontri. In
un albergo di Tunisi ho finito di scrivere la
seconda edizione del mio libro su Marika e Aldo
Moro. Non sono passaste molte lune eppure il
tempo cammina e cammina sulle onde che scivolano
nell’alta marea.
Oggi la
tragedia si intreccia ai suoni orientali.
Tunisi, Algeri e poi la Libia con la sua
stringente mediterraneità tutta araba tra i
solchi dei cammelli e il vento che giunge dalla
Sicilia.
Quest’Africa
del Nord è nel nostro Sud. Dovremmo non
disperdere i ricordi e neppure i pensieri. Sono
davanti al mare di Sicilia e ascolto le voci.
Chissà che fine ha fatto la mia tunisina
dall’accento arabo – francese – siciliano?
“Ma certo, noi
facciamo parte di un Mediterraneo degli
esclusi”. Con queste parole si allontanò da me.
Continuo a riflettere su questa frase tanto che
diventerà il titolo di un mo libro. Il
Mediterraneo degli esclusi. La vita, la poesia,
i poeti, gli amori, i viaggi. Un diario che
racconterà frammenti di destini.
Ma cosa ci
resta in queste dimenticanze che urlano l’oblio
di una civiltà? Mi ritornano come un fulmine
viola le mie passeggiate tra le viuzze della
Medina di Tunisi. Uno scialle bianco e nero sul
capo e sulle spalle. La Moschea con i suoi
tappeti. Puntuale l’urlo della preghiera. Ma
quando si prega non ha importanza essere
cristiani o musulmani.
Mi affascina
l’Islam. L’Islam di Nazhim. I suoi versi mi
lacerano l’anima. Ma Nazhim era nato proprio a
Tunisi. Nella città dei fuochi e delle fiamme
che cristallizzano il cielo.
“Mai mi
allontanerò dalla Medina./Cristo restituiscimi
il porto./Tu conosci le parole./Maddalena.
Maria. Giuda./Il cuore di pietra nel solco del
mare./La sabbia del tuo deserto io
parlerò./Parlerò le tue lingue/con
l’inquietudine in frantumi./L’acqua del tuo mare
io parlerò./Resto come vela nel porto dei nostri
destini./Cristo./Le mie preghiere sono nella tua
stagione/e il quotidiano è una ferita nel sale
dei giorni./Con te/io vivo”. Nazhim Abshu mi
accompagna con il suo pensare, i suoi versi, la
sua avventura.
Mi restano
questi versi tra le pieghe di un quaderno dalla
copertina nera. Ancora ci sono le luci nel
Mediterraneo. Tunisi mi sconvolge. Cerco altri
ricordi. Sono nella fuga dei misteri o nel volo
dei dervisci danzanti che ruotano nel cerchio
magico dell’infinito.
Un sogno mi
ripete: “Se hai coraggio dimentica. Se il
ricordo ti assilla non allontanarti. Il
paesaggio della memoria non ha orologio o
clessidra. Resta nei tracciati della magia. Un
mistero è una magia. Cristo è nel culto degli
sciamani. Ma solo il silenzio renderà bello
l’eterno. Abbiamo bisogno di bellezza e la
provvisorietà è nel giro tondo
dell’imprevedibile”.
Qui finisce il
sogno. Questo sogno. Non so se mi sarà data la
possibilità di ritornare a Tunisi. La Sponda
Sud. Ma non ho rimpianti e non credo al caso.
Non mi interessa la razionalità. Cerco di capire
la Provvidenza e mi affido non alla ragione ma
al mistero che custodisce i segreti. il vento di
Tunisi mi riporta echi e lo sguardo della donna
conosciuta in aeroporto mi accompagna.
Mi accompagna.
La donna con il foulard. Con la sua dolcezza e
con la sua sparizione. Il suo Mediterraneo degli
esclusi è nel mio diario. Ma perché mi ha
parlato del Mediterraneo degli esclusi? Donna di
Tunisi con il viso avvolto negli azzurri e gli
occhi che fissano il mistero.
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 25
Ottobre 2010
A 150 anni
dall’Unità d’Italia
GIUSEPPE
GARIBALDI: SOCIALISTA E LIBERALE?
Marx non amava Garibaldi!
E Garibaldi era lontano dal
materialismo marxista
di
Pierfranco Bruni
 E' tempo di consuntivi non solo politici ma
anche storici. Le riletture si fanno sulla base
di una ricostruzione e di una interpretazione.
Si parla e si parlerà ancora di Giuseppe
Garibaldi (Nizza 1807 – Caprera 1882) in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia. E' tempo di consuntivi non solo politici ma
anche storici. Le riletture si fanno sulla base
di una ricostruzione e di una interpretazione.
Si parla e si parlerà ancora di Giuseppe
Garibaldi (Nizza 1807 – Caprera 1882) in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Ci sono
alcune considerazioni di ordine ormai storico e
non più ideologico.
Su quale
storiografia si basa il “pensiero” politico di
Garibaldi? Una provocazione? Direi di no. Ma una
osservazione certamente sì.
Che Giuseppe
Garibaldi non fosse amato da Carlo Marx è un
fatto risaputo. Diciamo che a Marx non era
simpatico Garibaldi. Lo aveva addirittura
“stroncato”. Ciò è stato confermato anche da
“l’Unità” non molto tempo fa.
Si
potrebbe parlare di un Garibaldi eretico? Ma
ancora una volta storia, leggenda e mito si
ritrovano insieme nel tentare di ridefinire il
personaggio. La rilettura di Giuseppe Garibaldi
attraverso il volume (il cinquantaduesimo) del
Dizionario Biografico degli Italiani
aveva già posto delle riflessioni anche
politicamente provocatorie che dovrebbero aprire
una pagina significativa della nostra storia. Un
Garibaldi “altro” potrebbe anche mutare o
approfondire una visione dell’Unità d’Italia e
del Risorgimento stesso.
Mi sorge
spontanea una domanda che, a dire il vero, mi
ero già posto nei mesi scorsi, in una rilettura
complessiva dalla storia unitaria ai nostri
giorni, e che ora ritrovo nella sua attualità ma
anche nella sua sostanza storica.
Eccola.
E se,
chiaramente alla luce di una rilettura, Giuseppe
Garibaldi fosse, tutto sommato, un “pensatore”
dell’azione nazionalista? O un “garibaldino”,
rivoluzionario per dirla tutta, la cui idea
principale era quella dell’identità nazionale?
Fuori da qualsiasi concetto internazionalista?
Proprio così.
Ma sì.
La domanda non è peregrina. Bandiera del Psi
all’epoca craxiana. Il Craxi nazionalista e
difensore della Patria. Mito indiscusso del
leader socialista in quegli anni dai consensi
inebrianti. Craxi, in quel tempo, si sentiva un
Garibaldi redivivo. O con quali socialisti
starebbe oggi Garibaldi? Tra l’ironia e la
rilettura, piuttosto spinta sulle comparazioni,
Omar Calabrese aveva sottolineato un paragone
che andrebbe letterariamente approfondito.
Infatti si era
così espresso: “… nella giungla dove Sandokan
fugge con la Perla di Labuan, par di vedere
Garibaldi con Anita nella pineta di Ravenna”.
Calabrese ha condotto il suo discorso
spingendosi sulla popolarità di Garibaldi. Eroe
popolare ma anche eroe del popolo.
Renato
Zangheri, invece, aveva posto l'accento sul
Garibaldi socialista e sul ruolo dei contadini
nell’avventura garibaldina. Ha precisato: “I
contadini avevano assistito passivamente al moto
unitario. Ma quando entrarono nella vita dello
Stato negli ultimi decenni dell’’800 e nei primi
del ‘900, lo fecero in gran parte sotto le
bandiere del socialismo. Un socialismo riassunto
soprattutto dalla figura di Garibaldi”.
Franco Della
Paruta ha parlato del Garibaldi “convinto
internazionalista in America Latina”. Carlo Jean
si è soffermato sul condottiero risorgimentale.
Credo
che la figura di Garibaldi vada riproposta
attraverso una precisa contestualizzazione
storica in un quadro di rilettura generale pre e
post unitaria.
Fu socialista
e nazionalista, monarchico e liberale. Insomma
non lo si può lasciare ad una lettura
scolastica, ma va approfondita la sua posizione
all’interno di una temperie che nel corso di
questi decenni ha vissuto dei veri e propri
processi di ricerca e interpretativi.
A parte
questo, il discorso su Garibaldi nazionalista
può assumere una riflessione seria.
Si ricominci a
discutere del ruolo che ha avuto il Garibaldi
nazionale e nazionalista in tutte le vicende
politiche che lo hanno visto protagonista.
Nazionalista e liberale lo fu in tempi non
sospetti. Ma si parlò di un Garibaldi
“interventista dei nazionalisti” come si parlò
di un Garibaldi “profeta della dittatura” e poi
di un Garibaldi “progressista del Fronte
popolare”. Ma ci sono dati che vanno confutati.
I
liberali italiani, dopo che la Legione italiana,
da lui fondata nel 1843, difese Montevideo da un
cruento assedio e dopo la battaglia di San
Antonio al Salto dell’Otto febbraio 1846 nella
quale gli italiani ebbero una straordinaria
vittoria (fu in questa battaglia che i legionari
garibaldini adottarono la camicia rossa),
organizzarono una sottoscrizione in tutta Italia
per insignirlo con una spada d’onore.
Ciò è
soltanto un mero episodio trascurabilissimo in
confronto a tutte le posizioni assunte da
Garibaldi nel corso della sua attività politica.
Soprattutto bisognerebbe rileggere le sue
“Memorie” per rendersi conto della vera statura
del generale e della grandezza dell’uomo
politico, il cui senso della rivoluzione è
rompere gli steccati per creare libertà alla
tradizione, alla Nazione, alla Patria, alla
famiglia, attraverso quei modelli di libertà che
provengono certamente dal liberalismo ma anche
dal nazionalismo.
In molte
occasioni si potrebbe accostare Garibaldi ad
Antonio Salandra. Il primo Presidente del
Consiglio che unificò la conquista per la terra
ad una politica liberale. Un primo ministro che
veniva dal Sud, dalla Puglia, e conosceva molto
bene il rapporto tra le lotte per la terra e una
concreta politica agraria.
Molte
tappe segnate da Garibaldi sono da considerarsi
in quel profilo politico, in cui l’idea
dell’Italia si definiva nell’Idea dell’Identità
Nazionale. Un personaggio forse eretico. O un
generale eretico nazionalista. E lo ha
testimoniato più volte nel corso del suo impegno
e della sua attività. Sino a quando fu relegato
a Caprera, dalla quale si allontanò soltanto
dopo la caduta di Napoleone III per andare in
aiuto della Francia che era stata invasa.
Non va
trascurato il fatto che nonostante fosse stato
eletto in quattro dipartimenti non volle
partecipare mai alle sedute dell’assemblea di
Bordeaux. Nel 1874 venne poi eletto nel
Parlamento italiano. Si occupò di sovranità
nazionale e dei problemi inerenti le realtà
contadine.
La
guerra, per Garibaldi, era un fatto nazionale e
di popolo. Era sempre una guerra per la libertà
e non un fatto militare soltanto. Una guerra è
sempre, secondo Garibaldi, un coinvolgimento di
popolo e come tale va considerata: come
portatrice dei valori di una Nazione.
Ristudiare
Garibaldi certamente offre, oggi, una diversità
di valenze.
La storia non
finisce e non ha parentesi. Rileggere Garibaldi
tra il mito e la storia significa anche
reimpostare un processo storico che parte dalla
preparazione dell’Unità d’Italia, ovvero dalle
fasi post - unitarie.
Garibaldi,
personaggio che va letto attraverso due profili
che, comunque, non possono vivere separati: la
storia e il mito. Insieme costituiscono il
fascino di questo eroe dei “due mondi”.
Proprio
per queste ci sono spaccati che vanno compresi,
e in un tempo di perdute ideologie è necessario
riflettere con maturità e consapevolezza.
Giuseppe Garibaldi resta una personalità
controversa. Si pensi soltanto ai suoi anni di
riposo (o meglio di esilio) o ancora alla sua
“vertenza” liberale riguardante proprio l’Unità
d’Italia.
Garibaldi fu
un Generale che non accettò il marxismo e non
condivise i cosiddetti percorsi proletari.
D’altronde perché Bettino Craxi, che la storia
del socialismo la conosceva bene, lo aveva
indicato come riferimento partendo proprio da un
certo teorico del socialismo che rispondeva al
nome di Proudhon (Besancon 1809 – Parigi 1865)?
Il socialismo
ha nel suo Dna l’idea di identità nazionale.
Quell’identità nazionale per la quale i
socialisti interventisti difesero la Patria
proprio nella Prima guerra mondiale.
|
|
inizio pagina |
|
|
|
|
|