|
sei in
EDITORIALI
Arte
pag. 3
|
Editoriali,
recensioni e saggi di arte
|
|
|
pubblicato il 16 gennaio 2011
Sant’Agostino
di Mattia Preti alla Galleria Nazionale di Cosenza -
Palazzo Arnone
Ancora un dipinto
di Mattia Preti nella Galleria Nazionale di Cosenza.
 La
pregevole raccolta si arricchisce di una nuova,
importante acquisizione portata a felice compimento
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, su
proposta avanzata fin dal 2008 dal Soprintendente
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Calabria, Fabio De Chirico. La
pregevole raccolta si arricchisce di una nuova,
importante acquisizione portata a felice compimento
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, su
proposta avanzata fin dal 2008 dal Soprintendente
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Calabria, Fabio De Chirico.
La tela raffigura
Sant’Agostino, assorto nello studio, mentre
interrompe la scrittura per volgere lo sguardo
attento verso l’osservatore. L’immagine, isolata nel
buio dello sfondo, è illuminata con rapidi tocchi.
L’analisi introspettiva del volto e l’accurata
descrizione dell’abito vescovile conferiscono
all’anziana figura l’autorevole dignità di dottore
della Chiesa.
Il dipinto
potrebbe risalire al primo periodo maltese, fase
artistica che vide il Cavalier Calabrese
meditare attorno a suoi precedenti lavori, per
sperimentare, con l’ausilio della bottega, inedite
sintesi stilistiche.
L’opera sarà
sottoposta ad indagini diagnostiche e delicati
interventi conservativi al termine dei quali andrà
ad aggiungersi alla prestigiosa quadreria di Palazzo
Arnone, trovando definitiva collocazione negli spazi
espositivi dedicati al Maestro calabrese.
Scheda critica
Autore:
Mattia Preti detto il Cavalier Calabrese (attr.)
(Taverna 1613 - La Valletta 1699)
Soggetto:
Sant’Agostino
Materia:
olio su tela
Dimensioni:
cm. 187,5 x 133,5
Datazione:
sec. XVII (sesto decennio)
Il dipinto non è
firmato né datato. Il soggetto replica, con
varianti, il Sant’Agostino dell’Abbazia di
Montecassino, già assegnato dalla Utili (1989)
all’attività del Preti del sesto decennio.
Secondo il
giudizio di Spike (1999, p. 387-388) l’attribuzione
al Calabrese e la datazione dell’opera di
Montecassino ancora necessitano di una definitiva
conferma in quanto, trattandosi di una copia da un
dipinto probabilmente eseguito da Claude Vignon a
Roma tra il 1617 ed il 1624, <se fosse dipinta da
Preti, sarebbe stato in via di un esercizio
giovanile d’ammaestramento> (p. 387) e dunque se ne
dovrebbe ipotizzare una anticipata realizzazione.
Il dipinto di
Montecassino, rielaborando le invenzioni di Vignon,
tratte da Les quatre pères de l’Eglise
latine a Roma, presso la Curia Generalizia della
Compagnia di Gesù e dall’Apostolo San Paolo
nella Galleria Sabauda a Torino, presenta
Sant’Agostino, intento allo studio, mentre
interrompe la scrittura per volgersi verso
l’osservatore; l’analisi introspettiva del santo,
più incisiva di quella condotta da Vignon, insieme
alla descrizione accurata dell’abito vescovile,
conferiscono al soggetto raffigurato l’autorevole
dignità di dottore della Chiesa. Spike informa che
una copia della tela di Montecassino è a Dublino,
presso la National Gallery of Ireland (1999, p.
388).
Il dipinto romano
ripropone sant’Agostino, in uguale atteggiamento; il
volto, raffigurato di tre quarti, mostra gli stessi
intensi tratti somatici, più volte rappresentati dal
Preti. La tela presenta dimensioni maggiori rispetto
al dipinto di Montecassino, pertanto risulta
ampliata la struttura compositiva ai lati del Santo.
Il busto, isolato nel buio dello sfondo, è collocato
ad una maggiore distanza dal limite superiore della
tela e ciò conferisce all’immagine un maggior
respiro. Gli effetti della fonte di luce proveniente
dall’alto a sinistra sono resi sull’incarnato, sulle
vesti, sugli oggetti con rapidi tocchi.
Potrebbe trattarsi
di uno studio compiuto dal Preti nel primo periodo
maltese; dalla seconda metà del sesto decennio,
probabilmente il Calabrese era tornato a meditare su
precedenti lavori, avvalendosi di aiuti di bottega,
per sperimentare inedite sintesi.
Gli inventari di
collezioni storiche rivelano che la rappresentazione
a figura singola di un santo vescovo fu più volte
replicata dal Preti. Citati dal Getty Provenance
Index sono un <Santo Vescovo del Cavalier
Calabrese, in tela d’imper.[ato] re per alto>,
presente nell’inventario dei beni di Caterina
Chellini (Roma 1687) con altri dieci quadri del
Preti, diciassette del fratello Gregorio e sette di
Giacinto Brandi ed un dipinto con Sant’Agostino,
insieme ad un altro con Sant’Ambrogio, citato
nell’inventario dei beni della nobile fiamminga
Grunemberg Maria Gaetana (Napoli 1728).
Ufficio stampa:
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria
Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 21 Settembre 2010
MOSTRA di SPLENDORI SACRI
TESORI DELLA DIOCESI DI MILETO-NICOTERA-TROPEA
MUSEO STATALE DI MILETO (VV)
dal 26 Settembre2010 al 9 Gennaio 2011
Sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, la mostra organizzata dalla
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria, con il
coordinamento scientifico di Fabio De Chirico e la
cura di Rosanna Caputo, presenta una significativa
selezione di argenti sacri - dalla prima metà del
Trecento all’Ottocento - custoditi nelle chiese
e nei musei della diocesi.
Fra le opere più interessanti si segnalano le croci
astili di Gerocarne, di Pizzoni e di Motta
Filocastro.
Altri straordinari manufatti in mostra, il Riccio
di bacolo pastorale di Tropea e il Turibolo
di Mileto, concorrono a definire i portati
culturali ed artistici della Chiesa calabrese in età
aragonese ed il rapporto privilegiato dell’alto
clero con le più aggiornate botteghe della capitale.
Numerose sono le opere provenienti da Napoli
presenti nel territorio della diocesi che fungono da
modelli di riferimento per gli argentieri locali che
dimostrano, in tal modo, di conoscere e assimilare
lo stile dominante nella capitale.
Di assoluto rilievo le sculture in bronzo dorato di
Cosimo Fanzago, realizzate per il ciborio della
Certosa di Serra San Bruno, smembrato a seguito del
terremoto del 1783, presentate in questa mostra dopo
un delicato intervento di restauro.
Arricchiscono l’esposizione le sculture raffiguranti
Santa Domenica del 1738 di Gaetano e Nicola
Avellino, rinomati argentieri napoletani; San
Nicola, realizzato da Nicola De Blasio tra il
1741 e il 1747 e San Fortunato martire di
Gennaro Pane, argentiere napoletano tra i più noti,
attivo tra il 1835 e il 1878.
Il forte legame della Calabria con Napoli è
documentato ancora da una cospicua serie di opere,
dal Tronetto e dagli Ostensori
monumentali di Tropea e Nicotera ai preziosi arredi
sacri firmati da artisti quali Nicola Cangiani,
Giuseppe e Gennaro Del Giudice e Giovan Battista
d’Aula, attestati a Napoli tra il 1686 e il 1804.
Rilevanti, inoltre, sono i manufatti d’arte orafa
realizzati a Malta e a Messina, che testimoniano il
variegato gusto della committenza ecclesiastica
locale e l’abilità tecnica e stilistica degli
artefici isolani.
Completa la rassegna un’importante sezione, a cura
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e
di Vibo Valentia, costituita da pannelli
illustrativi delle chiese e dei complessi
monumentali da cui provengono le opere esposte,
architetture tra le più notevoli del territorio
della provincia di Vibo Valentia, quali le
Cattedrali di Mileto, Nicotera e Tropea, la Certosa
di Serra San Bruno, il complesso conventuale di San
Domenico a Soriano, la chiesa di San Leoluca a Vibo
Valentia, unitamente ad alcuni esempi “minori”, in
genere poco noti, che restituiscono un quadro
significativo dell’architettura chiesastica della
provincia di Vibo Valentia.
Il criterio espositivo ha inteso favorire la piena
fruibilità delle opere e la corretta lettura delle
stesse privilegiando un ordinamento per tipologia di
manufatti.
L’allestimento nasce, invece, dall’esigenza di
ottimizzare gli spazi valorizzando appieno le opere;
difatti, la dominanza assoluta del nero utilizzato
nella pannellistica, nella pavimentazione e nei
supporti, fa da contrappunto ai lucidi toni freddi
del metallo ed evidenzia le forme, i volumi e le
raffinate tecniche di lavorazione dei manufatti
esposti.
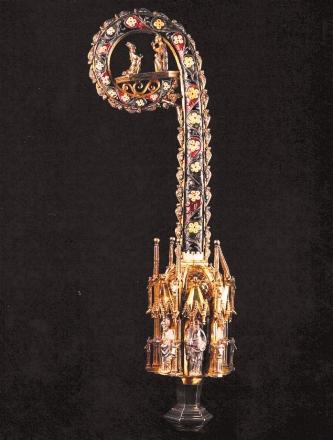
Riccio di bacolo pastorale
argentiere meridionale, sec. XV -
Tropea (VV), Museo diocesano
|
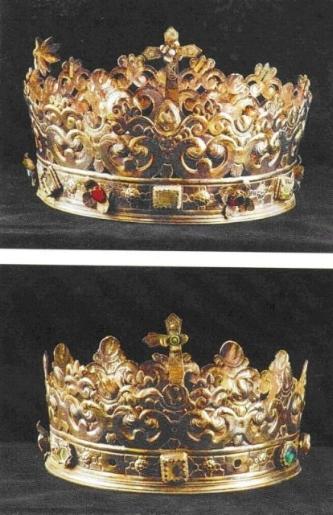
Coppia di Corone - Madonna delle Grazie
argentiere
messinese, sec. XVII - Nicotera (VV), Museo
diocesano
|

San Nicola di Bari
Nicola De
Blasio - (Napoli doc. dal 1729 al 1751),
secolo XVIII
Mileto
(VV) Museo Statale
|

San
Fortunato martire
Gennaro
Pane - (Napoli, doc. dal 1850 al 1878),
dat. 1877
Mileto
(VV), Museo Statale
|

Ostensorio raggiato con fusto figurato
(detto “Ostensorio del Capitolo” )
Biagio
Giordano - (Napoli, doc. dal 1770 al 1795),
dat. 1794
Nicotera (VV), Museo diocesano |

Angelo generale (lato dex)
|

Angelo generale (retro)
|

Putto 2 generale (fronte)
|

San Lorenzo generale (fronte)
|

San Ugo generale (fronte) |
|
|
Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Calabria
Soprintendente: Fabio De
Chirico
Ufficio stampa:
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria
Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
|
|
inizio pagina |
|
pubblicato il 5 Settembre 2010
LA NATIVITA’ DI PIETRO BERNINI AD
AMANTEA
Lo storico dell'arte Mario Panarello ha
recentemente rinvenuto in una dimora privata il
prezioso frammento della testa della Vergine
appartenente alla pala marmorea di Pietro Bernini,
raffigurante La Natività, conservata
nell'Oratorio dei Nobili di Amantea, di cui
si erano perse le tracce.
 Il
riconoscimento avvenuto su base stilistica è stato
comprovato dal combaciare del brano con la parte
mutila dell'altorilievo. Il
riconoscimento avvenuto su base stilistica è stato
comprovato dal combaciare del brano con la parte
mutila dell'altorilievo.
L'opera, databile agli ultimi anni del Cinquecento
rappresenta, nella produzione dello scultore
toscano, padre del più famoso Gian Lorenzo,
l'unico altorilievo presente in Calabria.
Ascrivibile al periodo giovanile dell’artista
documenta una notevole abilità tecnica e un’intensa
capacità espressiva in un linguaggio già definito,
che connota l'autore come uno dei più importanti
scultori della tarda maniera.
Questo straordinario ritrovamento rappresenta un
prezioso tassello che suggella l'attività della
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria, diretta da Fabio
De Chirico.
 E’
stato restituito alla pubblica fruizione il
frammento di un’opera d’arte di eccezionale
rilevanza. E’
stato restituito alla pubblica fruizione il
frammento di un’opera d’arte di eccezionale
rilevanza.
L’altorilievo raffigurante La Natività (marmo
statuario 150X100 cm. ca.), posto sull’altare
maggiore dell’Oratorio dei Nobili di Amantea è
un’importante opera della cultura tardo
cinquecentesca in Calabria.
Nell’Inventario degli oggetti d’arte d’Italia, II,
Calabria, pubblicato nel 1933, Alfonso
Frangipane attribuisce l’opera ad uno scultore
messinese, proponendo il nome di Rinaldo Bonanno. Lo
studioso lamentava la perdita di molti dettagli
causati dalla furia distruttrice delle truppe
napoleoniche che invasero nel 1807 il complesso
francescano di San Bernardino e l’oratorio annesso.
In particolare la scomparsa della testa della
Vergine privava l’altorilievo di un elemento
fondamentale per la sua lettura.
L’opera
è stata attribuita da Alessandra Migliorato a
Pietro Bernini (Tra Messina e Napoli: La
scultura del Cinquecento in Calabria da Giovan
Battista Mazzolo a Pietro Bernini, Società
editrice messinese di storia patria, Messina 2000,
pp. 99-112) e, accettata dalla critica successiva, è
stata accolta nell’imponente monografia dedicata
allo scultore da Hans-Ulrick Kessler (Pietro
Bernini (1562-1629), Hirmer Verlag GmbH, München
2005, p. 272).
L’altorilievo, sul quale ancora non si è rinvenuto
alcun documento specifico, si daterebbe intorno al
1592, anno di edificazione dell’Oratorio del Nobili.
Per convalidare l’attribuzione gli studi hanno
proposto confronti con le opere di Morano Calabro,
come la Santa Lucia e Santa Casterina
d’Alessandria, il Tabernacolo affiancato
da Angeli oranti per la chiesa conventuale di
Colloreto e con le più tarde statue dei Santi
Pietro e Paolo per la chiesa collegiata
di Morano.
Il rinvenimento presso una dimora privata del capo
della Vergine, di cui da più di due secoli si erano
perse le tracce, si deve allo storico dell’arte, il
calabrese Mario Panarello. Il riconoscimento
avvenuto su base stilistica è stato poi comprovato
dal perfetto combaciare del pezzo marmoreo rinvenuto
con la parte mutila dell’altorilievo. In tal modo si
è resa possibile una migliore lettura de La
Natività, visto che il capo della Vergine,
assorta nella contemplazione del Figlio, costituisce
uno dei fulcri dell’opera.
Dal punto di vista compositivo l’altorilievo si
presenta come una delle più complesse realizzazioni
del periodo giovanile di Pietro Bernini, che dalla
natia Sesto Fiorentino si trasferì nel 1584 circa a
Napoli. L’opera attesta una notevole abilità tecnica
e capacità espressiva mostrando un linguaggio già
definito che qualifica l’artista come uno dei più
importanti scultori della tarda maniera, sensibile,
attento ed aggiornato anche a ciò che si andava
elaborando in pittura. Ciò dimostra anche quanto la
Calabria fosse recettiva alle novità del momento.
Pietro Bernini,
formatosi sotto Rodolfo Sirigatti, avrebbe prima
soggiornato a Roma e poi si sarebbe trasferito a
Napoli. I primi lavori, eseguiti per Giovanni
Antonio Carafa, ancora non identificati, risalgono
al 1589. Sono documentate al 1591 le già menzionate
statue di Morano Calabro ed il tabernacolo per la
chiesa di Santa Maria di Colloreto che costituiscono
le prime opere note dell’artista. Queste, tuttavia,
non furono le uniche, ma aprirono la strada ad altre
commissioni calabresi, come l’Immacolata
nella chiesa di san Leone a Saracena dove pure si
trova una Madonna delle Grazie - esemplata su
un prototipo di Benedetto da Maiano sfruttato da
Antonello Gagini - già nella locale chiesa dei
Cappuccini. Importante, inoltre, la Santa Lucia
nella chiesa dei francescani di Polistena, mentre le
identificazioni più recenti del San Giovanni
di Gerace e di una copia del Laocoonte del
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria,
accrescono il catalogo di Pietro Bernini ed il
numero di opere calabresi.
Note sullo stato di conservazione e restauro:
La testa della Madonna è certamente pertinente al
rilievo de La Natività di Pietro Bernini.
Spezzata di netto all’altezza del collo, presentava
al centro dello stesso un piccolo foro di circa 1
cm di diametro e profondo circa 5 cm, praticato per
collocare il manufatto su una base a fini
espositivi. La porzione di naso mancante è stata
ricostruita da mani esperte, con gesso e polvere di
marmo. La testa comunque si trovava al momento della
donazione in buono stato di conservazione, con le
superfici pulite e cerate. Al fine di un suo
corretto riposizionamento è stato eseguito un
attento studio con un rilievo 3d finalizzato alla
riutilizzazione del foro esistente nella testa per
non creare ulteriori traumi al manufatto. Tale
soluzione non è stata praticabile in quanto la
Madonna è reclinata in avanti, in atto di adorazione
del Bambino.
Dopo una attenta documentazione fotografica e
grafica si è proceduto all’applicazione di un perno
in vetroresina di 8 mm di diametro, dopo aver
applicato sulle superfici uno strato di paraloid
B72 molto concentrato, al fine di creare uno strato
di sacrificio tra le superfici originali e la resina
epossidica UHU-Plus usata per fissare il frammento.
Non sono state eseguite stuccature di sorta in
quanto il manufatto presenta numerose lacune
provocate dall’atto vandalico coevo alla
decapitazione della Madonna. Il rilievo è stato
oggetto di un intervento di restauro eseguito in
tempi imprecisati, durante il quale l’uso di
sostanze aggressive ha in molti punti sbiancato le
superfici, lasciando intravedere “la pelle”
originale del rilievo solo nei sottosquadri, zone
risparmiate alla pulitura. Le superfici sulle quali
è stata applicata in passato uno strato di cera, si
presentano omogeneamente lucide non rispettando i
passaggi chiaroscurali creati dall’artista. Dopo la
ricollocazione del frammento sarà necessario mettere
a punto un intervento conservativo finalizzato a
riportare La Natività a quanto espresso
dall’artista, senza sovrapposizioni o
interpretazioni cui sono soggetti molto spesso i
rilievi marmorei.
Ufficio stampa:
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Calabria
Silvio Rubens Vivone – Patrizia
Carravetta
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
|
|
inizio pagina |
|
|
|
|
|
|
|